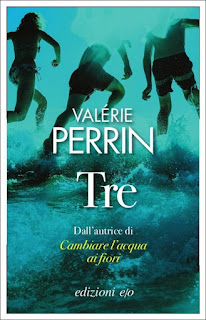MODA & MODI
Trent'anni dopo, ma con le stesse parole
“Una nuova austerity”. Si intitolava così, nel novembre 1991, la prima rubrica di moda del Piccolo. Trattandosi di abiti e accessori, un’autentica antenata di quella che state leggendo. Annunciava una svolta nel vestire per l’anno successivo: il 1992 sarebbe stato all’insegna della sobrietà, con gonne lunghe, pantaloni ampi e severi, giacconi di maglia. Fotografava la fine della sbornia dell’usa e getta, all’insegna del bisogno di «qualità, confortevolezza, economicità, riciclabilità». Cortocircuito temporale: queste parole non le abbiamo già sentite, non le ho scritte anche di recente?
Tempo di bilanci, dunque. Oltre ai 140 anni del Piccolo, personalmente festeggio un altro compleanno: il trentennale di questo spazio. Tre decenni a guardare e cercare di interpretare la moda e i suoi cambiamenti da un angolo di osservazione del tutto particolare, quello di una città che ha dato i natali o ha adottato celebri designer (Renato Balestra e Raffaella Curiel, Ottavio Missoni e Mila Schön), ma dove di moda non si è mai prodotto niente (a parte lo stabilimento degli abiti senza pinces che all’inizio degli anni ’70 Roberta di Camerino varò nel magazzino Sessanta del Porto nuovo per sfruttare le agevolazioni doganali). Una città dove novità e tendenze arrivano in ritardo, pressochè ignorate, e che implacabilmente tende a vestirsi sempre nello stesso modo, pratico e impersonale, anche quando griffato. Insomma, è stata una sfida quantomeno stimolante.
Forse non è un caso che questo anniversario cada in un 2021 anch’esso spiazzante e singolare, al termine di due anni contrassegnati da chiusure, riaperture, confinamenti, progressive liberazioni e per l’abbigliamento da una profonda rivoluzione. Ci sono le opportunità da cogliere nel mondo virtuale e c’è il dovere di contribuire a salvare il mondo reale dall’inquinamento: in entrambe le dimensioni la moda conta e può dare molto. Ogni bilancio sembra oggi più impegnativo, perchè la pandemia ha annientato certezze e accelerato trasformazioni, paradossalmente rallentando processi che sembravano destinati a durare per sempre, come la bulimia delle collezioni.
Cosa ci resta allora di questo 2021? Certamente alcune parole chiave. A cominciare dalla consapevolezza. Che significa trovare la propria misura nella sostenibilità: senza mortificazioni (che resistono poco), basta circoscrivere gli acquisti seriali, poco durevoli, destinati a una rapida rottamazione. Resta la circolarità. Senza improvvisarsi esploratrici di mercatini, pratica che richiede tempo e allenamento, è più facile cominciare a guardare in casa propria, disseppellendo dall’armadio giacenze dimenticate. E poi la libertà. A partire da un modo di vestire confortevole senza essere sciatto, che dal perimetro domestico del lockdown si è trasferito sulle strade, nei luoghi di lavoro, negli spazi recuperati di socialità: un vestire che con linee e materiali rispetta la mobilità, la praticità, il benessere, eliminando rigidezze e costrizioni, uniformi e dress code ormai diventati insopportabili. Infine, ritroviamo il tatto, un senso di cui a lungo siamo stati privati e che ci accompagna a riscoprire morbidezza, lavorazione, struttura di ciascun capo, ad apprezzarne artigianalità e durata.
Non la chiameremmo più “austerity”, questa parola sì è andata fuori moda. Le altre, trent’anni fa erano già tutte lì. C’è voluto un lungo percorso e un virus molto veloce per restituircele.