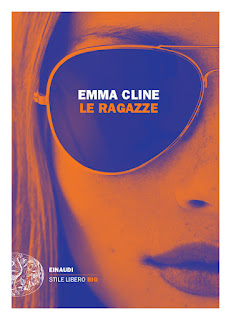Smetto di mangiare e divento una pianta
«Ho fatto un sogno» dice la giovane Yeong-hye per spiegare al marito un gesto dirompente nel loro scandito e anaffettivo menage familiare: si è svegliata nel cuore della notte e si messa a fissare il frigorifero, da cui, la mattina dopo, ha estratto tutta la carne - una provvista sostanziosa e costosa - per gettarla nell’immondizia. «Ho fatto un sogno» continua a ripetere all’uomo, spiazzato e subito seccato da quell’indecifrabile atto di ribellione all’ordine domestico e alle consuetudini sociali.
Nel cuore della notte Yeong-hye si è vista dentro un granaio, circondata e soffocata da enormi quarti di carne ancora gocciolanti di sangue. «Cerco di passare oltre ma la carne... non c’è fine alla carne, e nessuna via d’uscita. Ho del sangue in bocca, i vestiti intrisi di sangue appiccicati alla pelle».
Dopo quell’incubo, tutto sarà stravolto nella vita di Yeong-hye e dell’opaco signor Cheong, che aveva scelto la moglie proprio per le doti di arrendevolezza e passività, per l’inattitudine al confronto. Non sarà più vita, anzi, ma una lenta e allucinata discesa in quella che la protagonista intende sia la sua mutazione finale, una nuova forma di esistenza vegetale cui bastano il sole della fotosintesi, e l’acqua, per alimentarsi. Yeong-hye non vuole più mangiare carne, nè toccarla, nè cucinarla (lei che sapeva fare così bene brodi densi e speziati, manzi insaporiti e saltati, vongole e cozze tenerissime...). E nemmeno adempiere agli obblighi coniugali: «Il tuo corpo puzza di carne», risponde imperturbabile al marito.
Comincia così “La vegetariana” (Adelphi, pagg. 177, euro 18,00, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra) della scrittrice sud-coreana Han Kang, che ha vinto il prestigioso Man Booker International Prize 2016 battendo anche “Storia della bambina perduta” di Elena Ferrante, e già tradotto in nove lingue. Un racconto breve e crudele, affilato e fiabesco al tempo stesso, diviso in tre parti, che corrispondono alle tre prospettive da cui la vicenda è narrata: quella di Cheong, che non esita a usare violenza alla moglie, verbale e sessuale, per costringerla a tornare sulla sua decisione, quella del cognato, marito della sorella In-hye, un videoartista attratto morbosamente dalla nuova fisicità di Yeong-hye, al punto da dipingerne il corpo di fiori e poi possederla, accelerando la sua malattia e lo sconvolgimento dei rapporti dell’intera famiglia. Infine, quella della stessa In-hye, al cui racconto è affidata la parte più ardua, il crudo decorso ospedaliero, le costrizioni e le contenzioni, con la speranza di salvare la sorella attraverso il recupero della parte intatta e sognante dell’infanzia in comune.
 |
| Han Kang con la traduttrice inglese Deborah Smith |
Molte le chiavi di lettura di una storia ricca di simboli, e di temi, che avviluppa il lettore, con un finale sconcertante. Il sangue del sogno, quello delle bestie macellate, è lo stesso che Yeong-hye vomita nella fase terminale della malattia, quando i sanitari si accaniscono su di lei come un animale da squartare. È una violenza che parte da lontano, dall’infanzia della protagonista, dalle botte del padre, veterano della guerra in Vietnam, il primo che, davanti a tutto la famiglia, tenterà di forzarla ad aprire la bocca per spingerle dentro un pezzo di maiale e ripristinare così l’ordine rovesciato dalla sua testardaggine. Il matrimonio chiude Yeong-hye in una routine di convenzioni e indifferenza («prima che mia moglie diventasse vegetariana, l’avevo sempre considerata del tutto insignificante»: l’attacco del libro), anche l’amplesso col cognato è la soddisfazione unilaterale delle fantasie di lui, ossessionato dalla sua “macchia mongolica”, una voglia sopra la natica.
Il rifiuto del cibo diventa così l’unico modo che la giovane donna ha a disposizione per far sentire la propria voce, per rompere il muro delle convenzioni coniugali, familiari, sociali. L’unico modo per spezzare una catena di violenza, che è anche quella dei silenzi, delle regole di chi l’ha considerata prima la componente invisibile e innocua di una compagine dominata dal patriarca, poi la parte silenziosa e sfruttabile di un rapporto a due. Non è il rifiuto di chi chiede attenzione quello di Yeong-hye, ma di chi vuole difendersi dalle aggressioni esterne entrando in un altro ordine di relazioni, abbracciando una natura diversa dalla propria. E in questa dimensione vegetale gli alimenti non sono più necessari, con tutti i rapporti di forza che implicano, bastano sole e acqua. Una sottrazione volontaria, follemente lucida, che è la strada per la liberazione.
@boria_a